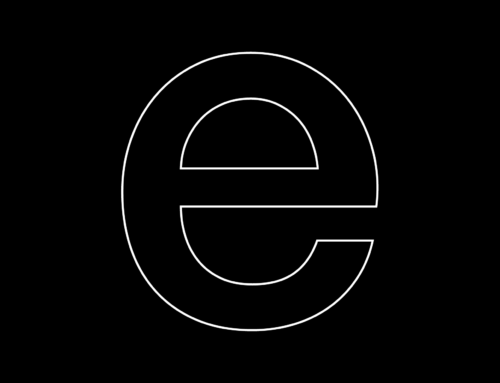Sono mesi che non possiamo uscire fuori, dobbiamo stare dentro. Istituzioni e organi d’informazione allineati ci dicono che è per il nostro bene. I non allineati gridano alla privazione delle libertà costituzionali. La strada si può vedere soltanto dalla finestra della propria casa, sempre che si abbia una finestra e si disponga di una casa, sempre che non si sia costretti a dormire in dodici sopra letti a castello in un lembo spurio di mondo, 28 metri quadrati calpestabili, oppure in rifugi di (s)fortuna destinati ai corpi espulsi da ogni società “rispettabile”. Una tremenda nostalgia dell’asfalto ci prende e ci piega. Ci alziamo e andiamo a letto dopo aver fatto pochi passi dentro la nostra casa. Chi ha un qualche nido, maledice lo Stato che gli impedisce di vedere la natura. Chi ha solo il fuori per esistere, maledice il destino che gli nega dalla nascita il diritto ad avere una casa, o almeno una stanza calda per passarci la notte. Poi ci sono coloro che, pandemia o non pandemia, hanno scelto da anni la strada e la casa non la vogliono: sono i nostri doppi deformati, l’enigma più oscuro che, se fossimo sani di mente, dovremmo impegnarci a sciogliere. A tutti, ricchi e poveri, è consentito andare al supermercato per affollarsi attorno a merci che hanno completamente assorbito la sfera del desiderio. Nel momento in cui scriviamo, è vietato andare a teatro e al cinema. Anche le gallerie d’arte e i musei sono state chiuse. Se Ballard avesse scritto un romanzo su un mondo così, l’avrebbero etichettato come il più distopico dei suoi universi.
La strada che si svuota
Questa è la nostra realtà di oggi. I colori non sono vocali alla Rimbaud ma semafori per il via libera o la prigione. Nel frattempo, la lingua inciampa su sé stessa, si impoverisce ancora di più. Gli occhi fanno tutto il lavoro del corpo e le poche sillabe che gli umani si scambiano tra di loro hanno a che fare con mascherine, ristori, governi cattivi e popoli irresponsabili. Una litania afasica di lamenti senza discorso accorcia ancora di più la strada che ci è concesso di fare da casa al lavoro, dal lavoro a casa, dal supermercato all’asilo, dalla stazione alla macchina. La strada è sparita. L’asfalto su cui camminare-correre-perdersi è ingoiato dall’apatia. Una traccia di violenza altrettanto apatica si diffonde nell’aria, rendendo la vita ancora più asmatica. Ma questo sentimento letargico e ostile non è nato con il Covid-19 né con le misure restrittive di questo ultimo anno. È il materiale di scarto di ogni epoca, il rischio dell’inaridimento. Ed è così che l’uomo, per vergogna di sé stesso, comincia ad attaccare indistintamente questo o quel nemico, ma sempre più debolmente, con una voce sempre più flebile, quella sì, dettata da questi tempi chiassosi e dalla generale incapacità di accogliere il silenzio, la calma della mente.
William Shakespeare si trovò ad affrontare quattro epidemie. Tra il 1593 e il 1594, quando Londra era devastata dalla peste e i teatri erano chiusi, il drammaturgo inglese scrisse due poemi fantastici, Lo stupro di Lucrezia e Venere e Adone, curandone poi personalmente le stampe. Non tutti devono essere Shakespeare (sulla cui identità peraltro ancora gli esegeti si accaniscono: era forse un italiano, erano tanti, era solo uno pseudonimo?). Non è questo il punto. Il punto è la paura mortale della stanza in cui stare fermi, immobili, se necessario. «Quando mi sono messo qualche volta a considerare il vario agitarsi degli uomini e i pericoli e le pene, ho scoperto che tutta l’infelicità degli uomini dipende da una sola causa: non sapersene stare in pace, in una stanza»: Blaise Pascal ha scolpito questa verità antipatica nel Seicento (dai Pensieri sulla Felicità). Non abbiamo fatto tanti passi in avanti da allora. Che cosa ci fa paura dell’immobilità? Potendo contare su una “stanza tutta per noi”, di che cosa potremmo mai lamentarci? In un certo senso, abbiamo tutto. Pensando alle donne e alla scrittura, Virginia Woolf individuava nell’immagine di Una stanza tutta per sé il segno di una indipendenza foriera di creatività. Con ciò, non vogliamo portare avanti istanze di genere e ancor meno pretese intellettuali. La stanza tutta per sé può diventare, semplicemente, sinonimo di mobilità di pensiero, attenzione, presenza, acutezza percettiva, varco spazio/temporale dell’accadere.
Sulle tracce di Bartleby
Nella sua totale enigmaticità, appare a questo punto sulla nostra soglia la figura sottile di Bartleby lo scrivano. Lo facciamo entrare nel discorso usando le parole del suo creatore, Hermann Melville: «In seguito a un mio annuncio, un giovane immobile (corsivo nostro, ndr.) comparve una mattina sulla soglia del mio ufficio, la porta essendo aperta perché si era d’estate. Vedo ancora quella figura, pallidamente linda, penosamente rispettabile, incurabilmente sconsolata. Era Bartleby». Questo «motionless young man» riaffiora dall’inconscio come prefigurazione di un mistero che apparenta l’umano e la cosa, come segno siderale di un eterno presente che si manifesta attraverso un ritirarsi della parola: «I would prefer not to» («Preferirei di no»). Bartleby preferirebbe di no: non accondiscendere, non trafficare con gli altri avvocati e copisti, non correre per le strade di New York per fare qualcosa che potrebbe rivelarsi insensato. Bartlebly preferisce copiare, semplicemente, con meticolosità, quello che gli viene dato da copiare. Bartleby fa sua una stanza non sua. Bartleby se ne sta lì, al centro della stanza, immobile, ascetico, imperscrutabile. Nella sua immobilità c’è un segreto, la disobbedienza nei confronti di una specie che ha tradito sé stessa, pensando di evolversi attraverso la parola utilitaristica e l’azione forsennata. Benché nel finale il narratore accenni a una qualche influenza negativa che un antico mestiere tombale potrebbe avere avuto su Bartleby da ragazzo, non ci muoviamo qui nel campo della psicologia. Bartleby è un’apparizione immobile (motionless) che viene da non si sa dove e va non si sa dove. Bartleby non fa nulla e non dice nulla. Più simile a una cosa, porta nel suo comportamento e nella sua essenza fantasmatica «la libertà da ogni dissipazione» («his freedom from all dissipation»).
Il problema è nella dissipazione della vita. Non della “vita moderna” rispetto a chissà quale altra vita “non moderna”. Della vita e basta. La dissipazione porta a girare a vuoto, preda dei venti, del commercio delle anime (e dei corpi), della chiacchiera e dell’opinionismo (oggi vero grande cerimoniere delle nostre vite). Il contrario della dissipazione non è la conservazione, né la pura sopravvivenza. Il contrario della dissipazione ci consegna un’aporia, un paradosso, un enigma che cerca di volta in volta stanze tutte diverse per abitare il proprio segno iconografico, il bagliore epifanico. «Accadere, passare, trascorre, arresto, immobilità: l’attimo, e nell’attimo la lacuna, l’interstizio, il vuoto» annota il filosofo Franco Rella in “Minima Temporalia”, l’ultimo capitolo del suo denso viaggio tra le Immagini del tempo: da metropoli a cosmopoli (Bompiani, 2016).
Affinare la percezione
L’arte, la letteratura e la poesia ci offrono infinite finestre cui affacciarci per scorgere quel barlume. Ma l’aporia rimane ugualmente. Come mai? È l’uomo Sapiens che l’ha portata. È nella sua pretesa di superiorità che l’essere è stato ridotto ad ente. In questo senso, non esiste un’epoca migliore di altre. Pasolini si dannò tutta la vita per risolvere la tragica contraddizione tra uomo e mondo, tra l’amore per la vita e la vita stessa, tra l’ideologia e la cosa. «Non c’è cena o pranzo o soddisfazione del mondo, che valga una camminata senza fine per le strade povere dove bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani» scrive nei versi finali di Solitudine. Ma Pasolini sapeva bene che lui, come uomo, non avrebbe mai potuto farsi cane. Immagini come queste nascevano in lui, e lo ammise, da «una tentazione di santità». Provò vergogna, Pasolini, per il suo stesso «cuore elegiaco» che gli faceva idealizzare l’epoca pre-industriale, i corpi incoscienti dei ragazzi di vita o l’Africa incontaminata. Per questo cercò la ferita e infine la morte. «Io, che per l’eccesso della mia presenza, non ho mai varcato il confine tra l’amore per la vita e la vita» (La realtà).
Oggi, di che cosa è fatta la nostra realtà? Che cosa riusciamo a vedere? Dove si annida la vita? Ci dicono che bisogna esseri sani, che bisogna vivere in sicurezza. L’unico mito d’oggi sbatte furiosamente contro le pareti strettissime del controllo. Sembra aver vinto l’illogica dei sani. E mentre ci affanniamo a prolungare, in sicurezza, i nostri giorni, siamo sempre meno capaci di accettare la nostra tremenda, ma inesorabile solitudine, senza la cui consapevolezza sarà complicato accedere a qualche traccia di vita residuale. Tramontato il sogno di una vita migliore o di una età dell’oro, ci affanniamo a regolare i nostri orologi sui colori che ci indicano la libera uscita. E quando finirà la pandemia e la paura del virus, ci inventeremo altri nemici e altri deboli consumi. Tutto, fuorché abitare la nostra anomalia. Per il momento, vogliamo solo uscire. Per andare poi dove? Non è vero che sappiamo camminare. Come non sappiamo stare fermi. Soprattutto, non sappiamo vedere.
E se cambiassimo la prospettiva? Se ci disponessimo ad essere guardati? Più che affannarci a nominare la cosa, a formulare “il sogno di una cosa” (Enzo Golino sul Pasolini pedagogico), forse dovremmo aspirare a farci cosa. Un salto di specie, una fusione tra materia organica e inorganica, un’idea concreta, un movimento inaudito nella materia stessa: tutto può sempre accadere. Anche dentro la propria stanza. Soprattutto, dentro la propria stanza, che può rivelarsi straordinariamente popolata di esseri.
«Spesso mi interrogo per vedere chi sono – e chi sono nel momento in cui, sorpreso nudo, in silenzio, dallo sguardo di un animale, del mio gatto, sì, io faccio fatica a superare un disagio…Al centro ottico di una tale riflessione si troverebbe la cosa» scrive Derrida ne L’animale che dunque sono (Jaca Book, 2006). È la stessa conclusione a cui, molti anni dopo, interrogando Heidegger e lo stesso Derrida, arriverà il filosofo Felice Cimatti: «Invece di fingere di non esserci per far parlare le cose, occorre forse mettersi nella condizione di farsi guardare dalle cose stesse. Il problema delle cose siamo noi umani, che pretendiamo di non essere delle cose…Farsi guardare dalla cosa. Di questo si tratta» (Cose. Per una filosofia del reale, Bollati Boringhieri, 2018).
Pensiamoci un attimo. Sarà un pensiero impossibile da pensare veramente, ma è tutto quello che ci resta: accedere a uno spazio-tempo in grado di disarticolare, anche se per poco, la contraddizione del fuori e del dentro, la tirannia dell’io, l’ideologia di un altrove che ci salvi o la nostalgia di un prima.
Arresto, accadere, passare, attimo, lacuna, interstizio, vuoto. Allenare i sensi. Osservare. Farsi osservare. Disporsi al mistero. Ora. Qui. Il movimento più vivo nell’immobilità.