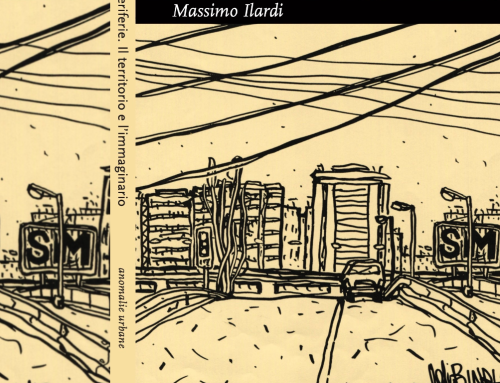«La speranza è la forma normale del delirio»
Emil Cioran, Squartamento
“Ce la faremo”. “Andrà tutto bene”. E poi arcobaleni e bandiere nazionali. La musica dai balconi. L’eroismo, le lacrime, gli imperativi morali, le metafore militari, le morti nelle RSA, una sigla anodina per dire le discariche dove le democrazie liberali sversano i propri vecchi. E poi l’inno diffuso dagli altoparlanti, il giornalismo della paura con immagini usate come clave, il disseppellimento rituale di quel cadavere nostrano chiamato senso di comunità, ma sopra tutto la dignità di cartapesta e sputo dietro la quale fin da subito hanno fatto capolino gli affari più o meno leciti, le cordate di amici degli amici. Vera e propria morte a credito. La consueta pornografia nostrana. Al solito, nessun realismo, quello alla radice del futuro che si genera nel momento presente.
È questa la recita aberrante in cui ormai da un anno sguazza il nostro Paese, capace di riaffermare con orgoglio, anche in questa situazione, tutti gli stereotipi quanto mai concreti del proprio sentimentalismo piccolo borghese, entusiasta di annaspare nei suoi stessi deliri, del suo midollo irresponsabile e plebeo, soffocato dai suoi stessi fantasmi, strutturalmente incapace di confrontarsi razionalmente – dire politicamente sarebbe già una concessione eccessiva – con le questioni della vita materiale (cosa di più materiale della sanità pubblica?) e di trarne comportamenti conseguenti, sia da un punto di vista istituzionale che, all’occorrenza, di conflitto sociale. Una società, la nostra, incantata nel gesto di guardare altrove: quel sortilegio di un futuro che non è mai arrivato, una coazione a ripetere infantile e spietata. Un atteggiamento che suggerisce, fra i sentimenti possibili, solo quello di una radicale passio destruens che ci sottragga al ricatto di un avvenire mai avverato, ed allo stesso tempo ci distrugga internamente, per permettere l’autentica passione di trascendere il proprio misero egoismo, verso un obiettivo di là dall’orizzonte di gretti calcoli personalistici.
Afflizioni ed affezioni di lungo corso, quelle che invece ammorbano questa penisola, che nella miscela esplosiva di dinamiche epidemiche e sregolato desiderio, di conformismo consumistico ed individualismo sfrenato quanto idiota, hanno dato la stura ad un profluvio di retorica. Il condensarsi in una coltre tossica di tutta la congerie di buone intenzioni, repentini innamoramenti e sdegnosi volta schiena, roboanti dichiarazioni e indomita fiducia, tutti i costanti inseguimenti al ribasso, alle pretese del “perlomeno”, al vanto di primati esistenti solo nelle illusioni del politicante di turno, del coreuta, dell’affiliato, fino all’attuale ammucchiata del potere. Ma questa non è indignazione. L’indignazione stessa, semmai, è l’ennesimo sottoprodotto di scarto di un meccanismo ormai perfettamente funzionante. Un lubrificante per la cui produzione, come per quella di sistemi reazionari e repressivi, di controllo sociale e conformismo, siamo all’avanguardia da oltre un secolo. Ultima realizzazione in tema di lubrificanti, in questo senso, è quella del populismo di rete del M5S.
Il Partito Unico Liberista
Il meccanismo in questione, al di là della sua attuale coloritura politica – quella di Partito Unico Liberista – si auto replica sulla lunga durata storica dell’Italia, in una continuità asfissiante e costantemente giocata al ribasso. Dalla provvidenza manzoniana al “Ce la faremo”, dall’Uomo della provvidenza al balcone – quante icastiche ricorrenze – al grande tecnico che ci salverà a suon di macelleria sociale, dal Migliore che calciò fuori dall’orizzonte politico la rivoluzione, per tenere la palla nel giardinetto sorvegliato di una democrazia di mezzucci, alla fauna liberal del PD. Sempre, a svilire e svenare ogni costruzione collettiva, ogni sforzo ideale, il morbo di una speranza che non ha nulla a che spartire con quella figlia della potenza messianica, “sol dell’avvenire” ideologico, sprone al sacrificio, alla lotta, cifra del desiderio di portare il cielo in terra. Di nuovo ed ancora: quel che dovrebbe infine sfondare questo perenne fondale di cartapesta sul quale si muove la psicologia sociale italiana, non si afferma. Neanche a prezzo di 100 mila e passa morti. L’idea del male, che sia di natura morale, religiosa, politica od etica, pare non sfiorare minimamente l’animo degli italiani. O se lo fa, suggerisce esclusivamente la prudenza, la contrattazione al ribasso, il retrobottega della coscienza. Non suggerisce mai il fuoco di un’autentica fede messianica – quella esplosa in Iran dopo secoli di quietismo – né la fede rivoluzionaria di voler trascinare qui ed ora la trascendenza del regno dei cieli, fosse pure nella più materialistica delle rivoluzioni, come nella Rivoluzione d’Ottobre. In Italia non ci sono mai state rivoluzioni, ed a parte la settimana rossa del 1914, bisogna risalire alla rivolta dei Ciompi del 1378 per trovare segni di una sommossa. Il presente pare sempre dilavare, l’azione concreta è sempre minata da chi la pospone per le più svariate ragioni, in primis il ceto intellettuale, erede secolare di forme di elitismo dure a morire perché intrinsecamente funzionali a questo meccanismo.
Svuotare la piazza e la strada
È il meccanismo di questa morbosa speranza l’autentico disvalore al cuore del sistema di espressione sociale e politica italiano. Una speranza plasmata per secoli dal conformismo di un cattolicesimo incline alla spettacolarizzazione delle forme di vita collettive, ed allo stesso tempo inculcatore feroce di una perenne dissimulazione. Entrambe le dinamiche giocate sulla sottrazione del rapporto col sacro quale espressione del desiderio. Due spinte divergenti tese a svuotare la piazza e la strada, per così dire, lasciando il soggetto nella solitudine del suo piccolo mondo spietato, e allestendo la dimensione pubblica quale spettacolo, giostra, evento (un termine che tradisce l’origine religiosa di questa dinamica) ad esclusiva cura del palazzo. Un meccanismo teso a smorzare l’eccesso di conflitto politico e sociale ed il cui funzionamento, nella durata storica, si è rivelato più che vincente, ogni volta capace di declinare le aspettative collettive nelle forme e nei modi più rassicuranti della delega, dell’affidamento, della fiducia, della provvidenza e della sua incarnazione attuale, la tecnica finanziaria. Un meccanismo perfetto per sottrarre alle mani la cima della corda, sic et simpliciter ogni iniziativa autonoma, organizzata o meno.
Non è per caso che in un solo secolo abbiamo letteralmente inventato il fascismo, il cattocomunismo, la telecrazia ed il populismo di rete, tutte forme di recupero del conflitto e di diffrazione dell’azione – se non per lo stretto necessario (col tempo sempre minore) ad intaccare le strutture di potere per impadronirsene. Che fosse il recupero di un passato da riattualizzare in risibili forme imperiali, la rivoluzione contro l’animo borghesuccio (in realtà il vero fil rouge che ha unito sottotraccia tutte le suddette invenzioni), il tradimento della resistenza in nome di un dubbio pragmatismo dagli esiti ormai noti e spietati, o la pretesa ad un benessere dettato dalle logiche padronali – altra aspettativa incubata dal craxismo e di cui grazie a Forza Italia il Paese, per venti anni, si è nutrito grazie ad un pastone mediatico rivoluzionario – od infine la pretesa gretta e populista che si potessero recuperare le forme della democrazia diretta attraverso la rete, immaginando per tutti i servizi di un albergo 5 stelle – davvero un delirio plebeo – ecco, è chiaro che in ognuno di questi casi il fulcro dell’immaginario personale e collettivo è sempre altrove, spostato, differito, fuori dall’agire storico concreto dell’hic et nunc, quell’attimo rivoluzionario, avrebbe detto Benjamin, in cui ci si arresta subito prima del baratro. In sostanza viene impedito quell’autentico delirare che ci fa uscire dal solco delle abitudini e delle forme predeterminate dal potere di turno, facendoci saltare fuori dal destino, che è il frutto avvelenato di questa speranza sfibrante e malarica. Si tratta di una diffrazione che però non ha nulla a che vedere nemmeno con i processi psichici di consolidamento tipici del disagio della civiltà (non a caso siamo una società apertamente infantile), né tantomeno con l’attesa messianica, che paradossalmente costituisce la reale spinta ad entrare ed agire nella storia tipica della speranza religiosa, manifestata in maniera epocale dai prodromi culturali della Rivoluzione d’Ottobre, riscontrabili proprio in un autore reazionario come Dostoevskij. Niente di tutto ciò. Per un paese come il nostro, invece, è nella dinamica di espropriazione del presente che va cercata la radice del male.
Un cinismo senza pietà
Questa pandemia ha portato alla luce, in sostanza, le linee di forza di questa impalcatura dell’immaginario sociale e di come il paese profondo percepisce se stesso. Nello specifico ha fatto emergere quel modo schiettamente italiano, fatto di immotivata fiducia e smemoratezza, incapace di arrendersi alla tragedia, di spezzarsi alla disperazione e dunque di segnare un discrimine oltre il quale avere la necessità di confrontarsi col “che fare?” Non si tratta dunque di una degenerazione, ma è esattamente la descrizione del funzionamento efficace e sistemico delle forme di autorappresentazione del Paese, della manifestazione della sua modalità di ricomporre le fratture del cambiamento, anche traumatico, senza per altro che questo implichi alcuna forma di pietà, anzi. Un meccanismo che definisce, da questo punto di vista, una delle società più statiche e conservatrici del pianeta, allo stesso tempo atavica, personalistica, fideistica, spettacolarizzata, effervescente e conformistica, impolitica, consumistica e classista. E di un cinismo codificato fin dai tempi di Machiavelli, grazie al quale gli italiani presto dimenticheranno, impazienti di tornare a sognare, consumare, brigare. Perché il passato è passato e del doman non c’è certezza.