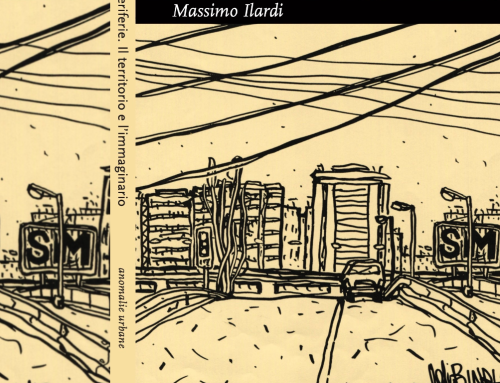Il 25 settembre una nuova tornata elettorale sta per essere inflitta al corpo sociale del paese, al suono di promesse che con lo scorrere dei decenni ed ora più che mai suonano e sono sempre più vuote, sconnesse dalla realtà, diffondendo non solo un’eco di disillusione, ma in modo del tutto lecito e politicamente sensato – per quel che in queste elezioni rimane di politico, ma soprattutto di sensato – una disaffezione ed un disinteresse radicali. La retorica tesa però a stigmatizzare il disimpegno e l’astensionismo, a questo punto, va smascherata fino in fondo. E va smascherata non in nome di strampalati ideali rivoluzionari fuori tempo massimo, o di una idea logora e strumentale di cartello e coalizione contro quello o per quell’altro, ma per così dire effettuando un esame bioptico dell’evoluzione del sistema elettorale sempre più teso a raggruppare il consenso e a livellarlo, del senso pragmatico e storico dell’ipertrofia assunta dal valore della forma democrazia. In ultima istanza ci si deve domandare perché, all’interno delle regole elettorali della nostra democrazia, sembrerebbe essersi innescata una deriva che nei fatti favorisce processi decisionali extra istituzionali, avulsi dalla sovranità popolare pur sancita dalla Costituzione, e allo stesso tempo non fa che agevolare di volta in volta la creazione di compagini di governo sempre più informi e supine a questo meccanismo, capaci solo di assecondarlo per trarne benefici di vario tipo al livello di schieramento, di clan, o personali. I governi Ciampi e Dini furono i precursori, ma quello Monti prima e l’attuale governo dimissionario Draghi – guarda caso quattro economisti e banchieri – costituiscono in questo senso una concreta messa sotto tutela del sistema democratico quale esso stesso pretende di essere, da parte delle concrete forze economico-finanziarie che detengono il potere, di là dai formalismi rappresentativi di cui non hanno più bisogno. In Italia così come nella quasi totalità delle democrazie liberali occidentali. Quello che soprattutto non si domanda nessuno di coloro che additano chi si astiene dal voto delle più innominabili colpe è perché, in che modo, il voto che a tutti gli effetti è una vera e propria delega di potere, abbia cessato di essere esercitato da ormai la metà degli aventi diritto, con il risultato piuttosto evidente che i partiti, i movimenti e le varie formazioni politiche che vengono votate, finiscono per rappresentare in Parlamento una minoranza del Paese, così come espressione di una minoranza sono le loro decisioni? Si tratta solo di regole del gioco? In realtà non si tratta di un vulnus, tutt’altro.
Crisi della democrazia
Sono queste le domande che nessuno si fa, neanche i più accorti commentatori politici, perché comporterebbero una riflessione dura e critica: da dove viene lo sfaldamento profondo che attraversa la democrazia, ed in particolare quella declinazione storica delle forme democratiche chiamata democrazia liberale? In sostanza, le democrazie che sembravano essere emerse vincitrici dalla guerra fredda, inclusa la nostra, si trovano oggi in una crisi di legittimazione fortissima, consegnate mani e piedi a poteri che le trascendono e ne determinano le scelte e spesso finanche i rappresentanti, così come fanno a meno del mandato popolare. Questo fatto, in forme inconsapevoli e magari sciatte, paiono però averlo capito solo i cosiddetti elettori. E lo esprimono, coerentemente, negando al voto un valore che in effetti il voto non ha più: quello di una reale delega di potere. Oggi il voto, e lo scrivo conservando tutta la mia diffidenza verso pensieri deboli di vario genere, è un mero apparato di cattura. Non vuol dire però che questa trasformazione sia frutto del tradimento degli astensionisti.
Alle ultime elezioni amministrative, notoriamente elezioni che attirano al voto una percentuale maggiore di elettori in quanto legate ad interessi concreti, alla richiesta di incidere sulla qualità della vita sul territorio, tese insomma a sollecitare interventi e/o a manifestare apprezzamento o ripulsa verso l’operato delle amministrazioni locali, l’astensione ha ottenuto la maggioranza, relegando a meno del 50% il voto espresso dagli aventi diritto. Questo è un segnale forse anche più preoccupante dell’inarrestabile declino delle percentuali di votanti alle elezioni politiche. Ma è un segnale che non viene mai messo in agenda, anzi. E le elezioni che si avvicinano, quelle del 25 settembre, non solo non fanno eccezione, ma casomai rappresentano un laboratorio di messa in scena del conflitto politico quale mero spettacolo codificato. Ci sono parole d’ordine, colpi di scena, vecchie glorie del palco, interazioni che ubbidiscono a canovacci ben delineati da ormai trenta anni, roboanti proclami, accuse di circostanza. Tutto un confliggere quotidiano che lascerebbe presupporre divaricazioni, scontri, divisioni ed ostilità. Uno spettacolo codificato, appunto, esaltato ed esteso all’ennesima potenza dalla glassatura simbolica delle rappresentazioni mediatiche. Fermo restando, invece, che in tema di politica economico-finanziaria, questione occupazionale, politica estera, immigrazione, istruzione/formazione/ricerca, sviluppo tecnologico e infrastrutturale, insomma tutti quei temi chiave che dall’inizio degli anni Novanta ad oggi hanno segnato l’evoluzione e l’aggancio con la modernità nella sua più larga accezione possibile, la continuità fra i governi che si sono succeduti è stata pressoché totale. Ad esclusione di lotte verbali, infatti, nell’effettualità dei provvedimenti di legge e delle leggi di bilancio, l’alternanza delle forze politiche al paese non ha mai segnato reali segni di discontinuità, ristrutturazioni degli investimenti, scelte di concreto cambiamento. Lo stesso ventennio berlusconiano non ha fatto che accelerare questo processo. Ma non l’ha innescato. Lo stesso Berlusconi è un prodotto del processo di torsione liberale della nostra democrazia – che secondo il testo costituzionale, invece, si definisce «Repubblica democratica» – avviato negli anni Ottanta con l’esplosione neoliberista.
Appiattimento dello scenario politico
La facilità, per necessità di sintesi, con cui tratteggio in maniera vaga tutto questo può essere tacciato di qualunquismo, ma non è che il riflesso di un appiattimento sostanziale dello scenario politico. A riconferma dell’appiattimento del panorama politico su di una dimensione univoca, c’è non a caso la camera di compensazione giudiziaria nella quale è dato sfogo agli scontri di potere che invece di tramutarsi in progetti politici, interventi legislativi e confronto parlamentare – in poche parole nel supposto gioco democratico – sono ormai integralmente faccende personali, di cordata e di soldo; e come tali relegate nelle aule di tribunale, che per la politica sono l’anticamera dell’obitorio.
Ecco perché, di nuovo, queste elezioni prossime venture non faranno che piantare altri e più profondi chiodi sulla bara che la democrazia liberale ha costruito non tanto per sé stessa – in quanto sistema politico è il migliore che la virulenza del capitalismo neoliberista potesse augurarsi – quanto per i diritti che erano stati acquisiti in anni di intenso e spesso feroce conflitto sociale: sanità, istruzione, lavoro, formazione. Una democrazia liberale, quella nella variante italica, incapace oltretutto di far crescere un’imprenditoria realmente capace di giocarsela sul mercato mondiale, di fare innovazione, di premiare la formazione avanzata. Insomma, tutti i difetti di un sistema liberista sommati agli smodati appetiti delle consorterie politiche, e un sistema di piccole e medie imprese da un lato falcidiato e frustrato e dall’altro ormai ottusa consorteria di bottega. Il risultato è il paese in cui viviamo.
Il 25 settembre quello che emergerà dalle urne sarà indifferente, rispetto al processo che ho cercato di delineare. Ci si ostina a credere in una sostanziale diversità fra gli schieramenti, ma quando anche il signor Salvini può affermare «Meloni premier? È la democrazia», si comincia forse a capire che non è “la nostra” democrazia ad essere in pericolo, ma che in realtà è essa stessa, oggi, storicamente, a produrre esattamente questo tipo di rappresentanza politica, dopo aver svuotato il voto di una reale incidenza sui processi decisionali. Al liberismo non occorre più, da decenni, il consenso elettorale che la sua democrazia ha garantito: lo ottiene con più efficacia e con maggiori profitti in altri modi.
[Immagine di copertina di Alesia Kozik]