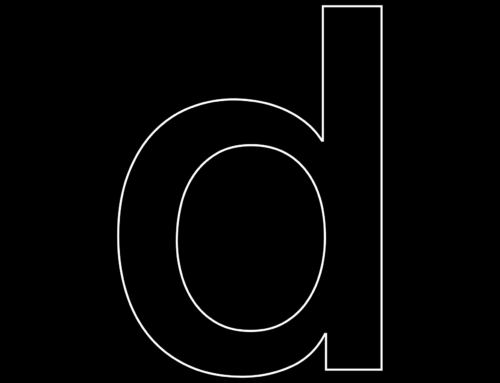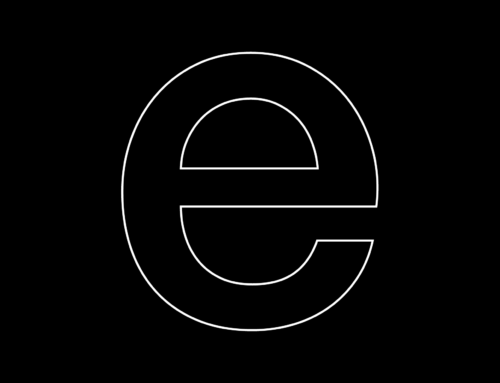In questo breve scritto sulla crisi e la sconfitta della sinistra, in particolare del Pd, nelle ultime elezioni politiche, vorrei tentare di riflettere sulle figure sociali che appartengono – per usare i termini della pubblicistica corrente – sia alla sinistra moderata sia a quella radicale, e che, pur essendo separate da alcune contrapposizioni ideologiche e da modalità diverse di intervento politico, sono però unificate da un retroterra mentale e culturale, che rende ancora possibile definire la loro identità come di sinistra, almeno nel senso che oggi si intende con questa parola. L’interesse è dunque rivolto non tanto all’arco di forze politiche che tale identità rappresentano, quanto piuttosto a quello che viene definito “popolo di sinistra” o, in modo pittoresco, “popolo della Ztl”. Ritengo, dunque, che tale identità esista, e che abbia un senso come disposizione mentale e come appartenenza culturale, che si proiettano entrambe su valori, comportamenti e significati che definiscono come “stare a sinistra” rispetto a un mondo che si muove, tuttavia, in altre direzioni e verso altri obiettivi.
Questa identità non si basa su categorie politiche forti, o su rapporti concreti e conflittuali di riconoscimento; non ha più una classe sociale di riferimento, non è più capace di riconoscere la natura delle lotte sociali e di individuare dove nasce il politico (come comportamento determinato dalla possibilità reale di un conflitto); di conseguenza, non è attrezzata a intervenire su quelle forme di conflittualità e di soggettività aggressive e individualistiche che attraversano oggi i territori urbani e che sono estranee alle idee di socialità cui tradizionalmente si ispira la cultura di sinistra. Tutta chiusa nelle aule parlamentari, o in quelle universitarie o nei centri storici delle città, la sinistra non conosce più i territori e le culture che li abitano (il riferimento è soprattutto alle periferie urbane, che sono quelle che contano di più in termini di consensi e di voti), e che sfuggono ai modelli consueti di governabilità: vere e proprie culture di resistenza alle regole del sistema, arcipelago spontaneo di pratiche di ribellione, che incarnano una domanda di libertà assoluta che non costituisce alcun ordine, non s’incardina istituzionalmente, non si coniuga con un concetto di legalità, non si declina nelle forme della democrazia o della giustizia o dell’uguaglianza. È libertà e basta, e risponde alle domande: “chi la pratica, dove e quando?”, denunciando così un rapporto imprescindibile con luoghi reali e contesti materialmente determinati.
L’identità della sinistra, di tutta la sinistra, si innesta, invece, in primo luogo, su orientamenti universali generici, che fanno parte però del mondo dell’economia, della morale, della religione, e che andrebbero lasciati quindi ai Draghi, ai Calenda, a papa Francesco, e sono: l’etica del lavoro, proprio quando viviamo la fuoriuscita dalla società del lavoro e dalla sua etica, accanto all’emergere della nuova produzione intellettuale, che non richiede più al lavoro né onorabilità né dignità; il senso dello Stato, alle cui dande la sinistra non riesce a sottrarsi, ma che è rarissimo trovare in un Paese come il nostro, che fa della fazione, nel bene e nel male, il suo principale modello culturale e organizzativo; la difesa dei diritti civili, a scapito, molto spesso, di quelli sociali; l’ecologia, che invece di assumere, per imporsi, il volto demoniaco della politica viene rappresentata da quello imbelle della giovane Greta; l’integrazione e i beni comuni, ma la questione è che senza un’azione conflittuale che li inneschi e li organizzi non esiste un “comune”, e una integrazione, che siano solo un parto della teoria o di una istanza etica; la questione morale che, anteposta a quella politica, è destinata a fare la fine da quella lanciata da Enrico Berlinguer sul finire degli anni Settanta; la ricerca ossessiva della coesione sociale, in un mondo in cui la società si frantuma sempre più in minoranze; l’utopia di un altro mondo possibile e la sacralità della memoria, anche se il più delle volte si pretende di trasmetterla come inutile e noiosa eredità, sentimento questo che – piaccia o no – ormai fa parte della società del consumo; l’ottimismo verso la natura umana, con la conseguente ricerca infruttuosa e maniacale dell’Altro. In secondo luogo, tale identità si innesta su comportamenti legalitari, politicamente corretti, rispettosi delle regole, integrati nelle istituzioni dello Stato; e, infine, su processi mentali derivati da una tradizione storica seppure recente come l’antifascismo, la Resistenza, la intoccabilità della Costituzione, l’europeismo e l’atlantismo, spesso accompagnati dalla idiozia del “senza se e senza ma”. (E a proposito di ciò, un inciso: non si è mai sentito in un dirigente democristiano, anche durante gli anni più bui della guerra fredda, tanto odio come quello espresso da Draghi nei confronti della Russia. Ma la Dc faceva politica e Draghi, come si sa, è solo un tecnico dell’economia di mercato).
Tutto questo definisce lo “stare a sinistra”, secondo i suoi sostenitori, i suoi militanti e il loro ceto politico, che si rispecchia negli stessi orientamenti universali, negli stessi processi mentali, negli stessi comportamenti istituzionali. E comunque è così che viene percepita la sinistra da ampi settori della società.
Allora, i motivi della lunga sconfitta del Pd, che parte almeno dal 2008, non riguardano solo i segretari politici che si sono susseguiti nel corso degli anni, e in particolare Enrico Letta che, come un frate francescano, ha anteposto una questione morale (non più alleanza con i 5 Stelle perché hanno fatto cadere il governo Draghi, come se in democrazia far cadere i governi sia un fatto rivoluzionario) a una decisione politica che, pur di vincere e conquistare il potere, impone invece di allearsi anche con il diavolo. Né vanno attribuiti, tali motivi, solo ai mezzi di informazione alleati – anche se è vero che sono tutti allineati e coperti dietro le parole d’ordine della legalità, del senso dello Stato, del politicamente corretto e di un buonismo a dir poco irritante, sebbene sia altrettanto vero che, a livello sociale e territoriale, contino poco o nulla. I motivi, allora, vanno imputati a tutto il “popolo della sinistra”, eletti ed elettori, giornalisti e conduttori televisivi, dirigenti e militanti, moderati e radicali, per il modo in cui parlano e si muovono nell’arena politica, sempre con il loro ditino accusatore di chi possiede la verità.
Conta poco, quindi, cambiare nome al partito, modificare l’organizzazione, sostituire i dirigenti, se la cultura, la mentalità, i valori rimangono gli stessi: minoritari, elitari, fuori tempo, alla fine sconfitti. Non si tratta solo di crisi delle forme organizzative, della deriva del suo ceto dirigente, del crollo di teorie ancorate a soggettività ormai scomparse; si tratta di qualcosa di più: appunto della mancanza di una cultura all’altezza dei tempi, il che rende insensibile a quel mondo della pura contingenza, dell’intensità dei desideri, dell’eccesso di presente, cioè alle modalità di vita oggi sperimentate dalla maggior parte degli uomini e delle donne. Davanti a comportamenti, che tracciano le linee di movimento di una società del consumo, la sinistra si rifugia nell’autoreferenzialità del politicamente corretto o, peggio, dispiega il suo vecchio apparato ideologico. Non solo: permane inossidabile in quello che è sempre stato un peccato di presunzione del pensiero democratico e di sinistra, con il suo lato oscuro che si chiama “rappresentanza”, e che consiste nello scambiare il pensiero di una élite per un’azione di massa.
La conseguenza più drammatica di tutto ciò è che, alla fine, inchioda la sinistra là dove il conflitto non c’é più. Ma senza conflitto non c’è decisione politica. E senza decisione, che è il cuore dell’agire politico, gli stessi diritti civili – che sembrerebbero essere al primo posto nell’azione del Pd, dato che la famigerata agenda Draghi, non a caso cara anche a Calenda, non gli ha permesso di fare una politica sociale degna del nome – sono destinati a deperire o, come avviene in molti casi, a restare fin dall’inizio lettera morta. Il fatto è che la politicizzazione del sociale, e cioè la capacità di tradurre cultura e conflitti in azione politica, che è stata da sempre, per la sinistra, lo strumento essenziale per esercitare egemonia, passa – ben prima del sogno di un altro mondo possibile – attraverso l’abilità di tradurre in politica quello che già c’è. Ma è proprio qui, su questa incapacità, che sembra consumarsi la crisi. Perché quello che c’è già ha a che fare con il particolare, la contingenza, l’essere “di parte”, e non con gli universali, da cui non può avere origine alcuna azione politica e alcuna decisione. La stessa produzione di soggettività, non a caso oggi bene molto raro nell’ambito della sinistra, può avvenire solo nell’opposizione a ogni universale.
(articolo pubblicato il 4.10.2022 su “terzo giornale”)
[Immagine in copertina di Alessio Ceccherelli]