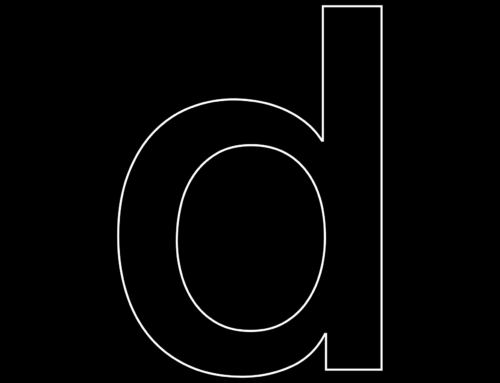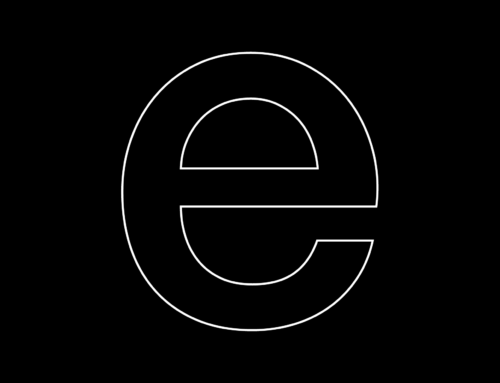Massimo Ilardi
Nel lungo elenco delle periferie investite dalle rivolte sociali di questi ultimi decenni mancano quelle delle grandi città italiane. Perché? I motivi sono diversi: per la mancanza di un vero passato coloniale di questo Paese non ci sono fenomeni di ghettizzazione spaziale connotati da comunità etniche o religiose coese ma escluse e separate; non esiste poi uno spirito nazionalistico come in Francia tale da imporre una omogeneizzazione e una integrazione forzosa a livello culturale; è presente invece una attitudine della popolazione autoctona all’accoglienza, a una mixité all’italiana; sussiste, infine, una struttura familiare che in parte ancora funziona e che riesce a mediare tra opposte tendenze. Ma per fare le rivolte ci vogliono gli individui, una massa di individui che sanno dire di no, che rompono la coesione sociale senza passare attraverso la mediazione politica o quella della “famiglia”. I paesi anglosassoni li possiedono: in alcuni casi li fornisce la tradizione religiosa, in altri la discriminazione razziale, in tutti l’odio verso lo Stato rappresentato sul territorio dalla polizia che li costringe nei ghetti e limita fortemente la loro libertà di movimento.
Sono motivi tutti validi ma che spiegano però solo in parte il silenzio delle periferie italiane. Qui è vero che non esiste alcuna frontiera che separa il centro dalle periferie e non alligna alcun fondamentalismo religioso, nazionalistico o di razza. C’è però, secondo me, un motivo che è vero più degli altri e che illumina la calma piatta non solo delle nostre periferie ma di tutto il territorio metropolitano. Dentro il processo di modernizzazione delle società occidentali, nella seconda metà del secolo scorso, la differenza italiana stava proprio nel connubio esplosivo tra cultura politica di massa e agire per fazioni che frantumavano questa radicalità sociale fino a portarla a livello individuale o di piccoli gruppi: messe insieme, queste due tendenze produssero una stagione lunga e violenta di conflitti sociali che non ha avuto riscontro nell’area occidentale e che permise a questo Paese di essere all’avanguardia nell’innovazione culturale.
Orfani della politica
Non è che oggi non esistano più la conflittualità e la violenza, quella che è scomparsa totalmente è invece una cultura politica di massa che ha prodotto come conseguenza una microconflittualità diffusa che però non ha più l’intensità, la diffusione, la forza di concentrazione che solo quella socializzazione politica, che traduceva cultura e conflitti direttamente in azione politica, era in grado di dare. La stessa cultura italiana, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, «si è ritrovata orfana dell’unico filtro – la politica appunto – che la può mettere in grado di raffigurare simbolicamente il conflitto e il mutamento sociale. Una cultura che non sa leggere, rappresentare, anticipare luoghi e forme in cui il conflitto si dispiega è una cultura agonizzante se non morta. Nel ventennio preso in esame [1960-1980] invece è proprio la pratica di una violenza comunque sentita come politica e l’esigenza di una sua rappresentazione che connette la produzione culturale con la realtà di una nuova società (D.Mortimer)».
Oggi si deve partire dalla consapevolezza che l’avvento del primato del consumo e di internet ha polverizzato l’azione politica, l’ha localizzata innestandola, nelle poche volte che riesce a operare, nelle vite delle persone e nella quotidianità dei luoghi. Questo ha comportato, da una parte, la mancata formazione di una leadership e, dall’altra la scomparsa dell’agire collettivo: non ci sono più classi, non c’è più popolo, quello che una volta veniva definito il popolo delle periferie, non c’è più società. Gli individui si dividono e si raggruppano in una miriade di minoranze sociali che sono l’aggregazione più immediata dove si coagula e si organizza oggi il senso di un gruppo, della sua azione, dei suoi interessi. È una forma dell’agire, un precipitato microsociale quello di organizzarsi in minoranze o fazioni che destruttura le tradizionali categorie e le vecchie strutture che dividevano e insieme legavano la società del moderno (appunto i ceti, le classi, i movimenti, il popolo, la moltitudine) e riorganizza sul territorio le relazioni sociali con strumenti e obiettivi diversi rispetto alle costanti e ai modelli del passato. È il sintomo di nuove contrapposizioni e di una forma di soggettivazione più conseguente alle modificazioni del tessuto sociale. A sostegno di ciò, Mike Davis scrive in La città di quarzo che «quello che rende le metropoli l’anello più debole del nuovo ordine mondiale é proprio la difficoltà del “combattimento asimmetrico” all’interno di teatri urbani “non nodali, non gerarchici”, contro milizie “il cui criterio di formazione è il clan” e che sono motivate da “disperazione e rabbia”». Ma sono proprio questa disperazione e questa rabbia, che pur covando anche nelle periferie di questo paese, non riescono più a politicizzare il conflitto, nel senso di tradurle in un’azione comune e di innalzare il livello dello scontro fino a trasformarlo in rivolta. Rimangono le minoranze sociali, quella che è scomparsa e la loro capacità di innescare un conflitto esteso a tutto il territorio di appartenenza.
Libertà e fazione
Prevale uno spirito di fazione, secondo la più nobile tradizione italiana, e di conseguenza una polverizzazione della lotta e degli obiettivi. Quel miracolo avvenuto negli anni Sessanta e Settanta dell’altro secolo che è riuscito a legare insieme fazione e azione politica di massa non è più avvenuto. E se non avviene, almeno qui in Italia, regnano l’indifferenza e la passività.
Le minoranze sociali non hanno comunque nulla di residuale ma si costituiscono come differenza, come soggettività che rifiutano di integrarsi dentro universali etici o istituzionali non solo per ragioni di interesse economico o culturale ma per esercitare potere in una determinata area dove selezionano funzioni e finalità con criteri di esclusione/inclusione, svantaggi/vantaggi. Potenze autoreferenziali che non rinviano ad alcuna dialettica politica o ad alcun trasferimento trascendentale dei loro obiettivi. La loro ascesa è la conseguenza più diretta della potenza del consumo, dell’apparire dell’individuo e della scomparsa della figura politica del cittadino sul territorio metropolitano. Se ci fosse (ma non so se c’è) una storia della mentalità degli italiani forse scopriremmo che non sono certamente “onore” e “patria”, come afferma lo storico Lucien Febvre, i sentimenti che ci accomunano come per i francesi, ma “libertà” e “fazione”: la libertà che viaggia con noi come individui e la fazione che è la ristretta dimensione territoriale a cui siamo disposti ad appartenere.
La politica, se di politica si può ancora parlare, si trasforma allora non più in attuazione di un programma ma in produzione di territorio e presidio di uno spazio sociale. Un luogo diventa il risultato di azioni e di relazioni sociali. Ma non sono le azioni e le relazioni ad assegnargli un senso, bensì il fatto che quelle azioni e quelle relazioni sono territorialmente determinate. Dunque, un luogo non é ereditato dalla storia o dalla memoria, ma é sempre una conquista sociale seppure intrinsecamente fragile perché legato alla capacità di una minoranza e della sua cultura di conoscerlo, nominarlo e soprattutto di perimetrarlo. Di produrlo materialmente. La trasformazione dello spazio neutro in luogo é, dunque, un atto di forza che implica l’affermazione di un potere sociale organizzato che si esercita su posti e contesti determinati che si muovono su una linea di confine molto stretta dove legalità e illegalità, politica e antipolitica, violenza e azione risoluta si confondono senza trovare molto spesso una soluzione.
Questo é un punto ribadito, ad esempio, anche dal documento Tutto il mondo in un frammento – Tre ipotesi sulla lotta in Val Susa distribuito durante il corteo del 25 febbraio 2012 in Val Susa dal movimento No TAV : «La potenza che si esprime in Val Susa deriva dal fatto che non si lotta contro delle astrazioni (il Capitale, lo Stato, una legge, l’inquinamento o la mafia per esempio) ma contro la maniera concreta –localizzata- attraverso cui queste astrazioni governano delle vite, configurano degli spazi, diffondono degli affetti.[…] La lotta non difende un territorio, ma lo fa esistere, lo costruisce, gli dà consistenza».
Condividere i nemici
Il territorio, dunque, non é mai considerato un bene comune ma il risultato di particolarismi in lotta tra loro e la cui misura e forma si rendono spazialmente visibili attraverso separazioni, esclusioni, enclavizzazioni. In questi luoghi più che altrove vale quello che afferma Cornac McCarthy in Meridiano di sangue: «Quello che unisce gli uomini non è la condivisione del pane ma la condivisione dei nemici». Ma l’essere contro ha un senso solo nell’essere dentro per riuscire a sfruttare al massimo tutte le risorse che il sistema concede anche se questo comporta la chiusura definitiva dentro un recinto. Qui sta la potenza distruttiva di questi particolarismi, non rispetto al sistema ma alle sue procedure di governo e alle sue regole di controllo.
La conseguenza è una frammentazione di poteri (chi predomina e comanda a prescindere dal consenso) che si guardano bene però di assumere una veste e una organizzazione da contropotere ma cercano invece di ritagliarsi spazi di autonomia e di sfruttamento delle risorse dentro la crisi delle istituzioni e della loro capacità di governo. Un fenomeno, tra l’altro, che anche qui segnala il fallimento di ogni sintesi o di unità. E lo spazio proietta concretamente questa dimensione, ne è espressione. E così il comune, la comunità, il collettivo, lo stare insieme e altre simili utopie/distopie se vogliamo a tutti i costi andarle a cercare non ci resta che farlo nelle reti. Ma sarebbe un altro discorso che nulla avrebbe a che vedere con quello che accade sul territorio. Anche questo insegnano le periferie.
*Questo scritto è tratto dal libro di M. Ilardi, Le due periferie. Il territorio e l’immaginario di prossima pubblicazione presso l’editore DeriveApprodi.
Nel lungo elenco delle periferie investite dalle rivolte sociali di questi ultimi decenni mancano quelle delle grandi città italiane. Perché? I motivi sono diversi: per la mancanza di un vero passato coloniale di questo Paese non ci sono fenomeni di ghettizzazione spaziale connotati da comunità etniche o religiose coese ma escluse e separate; non esiste poi uno spirito nazionalistico come in Francia tale da imporre una omogeneizzazione e una integrazione forzosa a livello culturale; è presente invece una attitudine della popolazione autoctona all’accoglienza, a una mixité all’italiana; sussiste, infine, una struttura familiare che in parte ancora funziona e che riesce a mediare tra opposte tendenze. Ma per fare le rivolte ci vogliono gli individui, una massa di individui che sanno dire di no, che rompono la coesione sociale senza passare attraverso la mediazione politica o quella della “famiglia”. I paesi anglosassoni li possiedono: in alcuni casi li fornisce la tradizione religiosa, in altri la discriminazione razziale, in tutti l’odio verso lo Stato rappresentato sul territorio dalla polizia che li costringe nei ghetti e limita fortemente la loro libertà di movimento.
Sono motivi tutti validi ma che spiegano però solo in parte il silenzio delle periferie italiane. Qui è vero che non esiste alcuna frontiera che separa il centro dalle periferie e non alligna alcun fondamentalismo religioso, nazionalistico o di razza. C’è però, secondo me, un motivo che è vero più degli altri e che illumina la calma piatta non solo delle nostre periferie ma di tutto il territorio metropolitano. Dentro il processo di modernizzazione delle società occidentali, nella seconda metà del secolo scorso, la differenza italiana stava proprio nel connubio esplosivo tra cultura politica di massa e agire per fazioni che frantumavano questa radicalità sociale fino a portarla a livello individuale o di piccoli gruppi: messe insieme, queste due tendenze produssero una stagione lunga e violenta di conflitti sociali che non ha avuto riscontro nell’area occidentale e che permise a questo Paese di essere all’avanguardia nell’innovazione culturale.
Orfani della politica
Non è che oggi non esistano più la conflittualità e la violenza, quella che è scomparsa totalmente è invece una cultura politica di massa che ha prodotto come conseguenza una microconflittualità diffusa che però non ha più l’intensità, la diffusione, la forza di concentrazione che solo quella socializzazione politica, che traduceva cultura e conflitti direttamente in azione politica, era in grado di dare. La stessa cultura italiana, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, «si è ritrovata orfana dell’unico filtro – la politica appunto – che la può mettere in grado di raffigurare simbolicamente il conflitto e il mutamento sociale. Una cultura che non sa leggere, rappresentare, anticipare luoghi e forme in cui il conflitto si dispiega è una cultura agonizzante se non morta. Nel ventennio preso in esame [1960-1980] invece è proprio la pratica di una violenza comunque sentita come politica e l’esigenza di una sua rappresentazione che connette la produzione culturale con la realtà di una nuova società (D.Mortimer)».
Oggi si deve partire dalla consapevolezza che l’avvento del primato del consumo e di internet ha polverizzato l’azione politica, l’ha localizzata innestandola, nelle poche volte che riesce a operare, nelle vite delle persone e nella quotidianità dei luoghi. Questo ha comportato, da una parte, la mancata formazione di una leadership e, dall’altra la scomparsa dell’agire collettivo: non ci sono più classi, non c’è più popolo, quello che una volta veniva definito il popolo delle periferie, non c’è più società. Gli individui si dividono e si raggruppano in una miriade di minoranze sociali che sono l’aggregazione più immediata dove si coagula e si organizza oggi il senso di un gruppo, della sua azione, dei suoi interessi. È una forma dell’agire, un precipitato microsociale quello di organizzarsi in minoranze o fazioni che destruttura le tradizionali categorie e le vecchie strutture che dividevano e insieme legavano la società del moderno (appunto i ceti, le classi, i movimenti, il popolo, la moltitudine) e riorganizza sul territorio le relazioni sociali con strumenti e obiettivi diversi rispetto alle costanti e ai modelli del passato. È il sintomo di nuove contrapposizioni e di una forma di soggettivazione più conseguente alle modificazioni del tessuto sociale. A sostegno di ciò, Mike Davis scrive in La città di quarzo che «quello che rende le metropoli l’anello più debole del nuovo ordine mondiale é proprio la difficoltà del “combattimento asimmetrico” all’interno di teatri urbani “non nodali, non gerarchici”, contro milizie “il cui criterio di formazione è il clan” e che sono motivate da “disperazione e rabbia”». Ma sono proprio questa disperazione e questa rabbia, che pur covando anche nelle periferie di questo paese, non riescono più a politicizzare il conflitto, nel senso di tradurle in un’azione comune e di innalzare il livello dello scontro fino a trasformarlo in rivolta. Rimangono le minoranze sociali, quella che è scomparsa e la loro capacità di innescare un conflitto esteso a tutto il territorio di appartenenza.
Libertà e fazione
Prevale uno spirito di fazione, secondo la più nobile tradizione italiana, e di conseguenza una polverizzazione della lotta e degli obiettivi. Quel miracolo avvenuto negli anni Sessanta e Settanta dell’altro secolo che è riuscito a legare insieme fazione e azione politica di massa non è più avvenuto. E se non avviene, almeno qui in Italia, regnano l’indifferenza e la passività.
Le minoranze sociali non hanno comunque nulla di residuale ma si costituiscono come differenza, come soggettività che rifiutano di integrarsi dentro universali etici o istituzionali non solo per ragioni di interesse economico o culturale ma per esercitare potere in una determinata area dove selezionano funzioni e finalità con criteri di esclusione/inclusione, svantaggi/vantaggi. Potenze autoreferenziali che non rinviano ad alcuna dialettica politica o ad alcun trasferimento trascendentale dei loro obiettivi. La loro ascesa è la conseguenza più diretta della potenza del consumo, dell’apparire dell’individuo e della scomparsa della figura politica del cittadino sul territorio metropolitano. Se ci fosse (ma non so se c’è) una storia della mentalità degli italiani forse scopriremmo che non sono certamente “onore” e “patria”, come afferma lo storico Lucien Febvre, i sentimenti che ci accomunano come per i francesi, ma “libertà” e “fazione”: la libertà che viaggia con noi come individui e la fazione che è la ristretta dimensione territoriale a cui siamo disposti ad appartenere.
La politica, se di politica si può ancora parlare, si trasforma allora non più in attuazione di un programma ma in produzione di territorio e presidio di uno spazio sociale. Un luogo diventa il risultato di azioni e di relazioni sociali. Ma non sono le azioni e le relazioni ad assegnargli un senso, bensì il fatto che quelle azioni e quelle relazioni sono territorialmente determinate. Dunque, un luogo non é ereditato dalla storia o dalla memoria, ma é sempre una conquista sociale seppure intrinsecamente fragile perché legato alla capacità di una minoranza e della sua cultura di conoscerlo, nominarlo e soprattutto di perimetrarlo. Di produrlo materialmente. La trasformazione dello spazio neutro in luogo é, dunque, un atto di forza che implica l’affermazione di un potere sociale organizzato che si esercita su posti e contesti determinati che si muovono su una linea di confine molto stretta dove legalità e illegalità, politica e antipolitica, violenza e azione risoluta si confondono senza trovare molto spesso una soluzione.
Questo é un punto ribadito, ad esempio, anche dal documento Tutto il mondo in un frammento – Tre ipotesi sulla lotta in Val Susa distribuito durante il corteo del 25 febbraio 2012 in Val Susa dal movimento No TAV : «La potenza che si esprime in Val Susa deriva dal fatto che non si lotta contro delle astrazioni (il Capitale, lo Stato, una legge, l’inquinamento o la mafia per esempio) ma contro la maniera concreta –localizzata- attraverso cui queste astrazioni governano delle vite, configurano degli spazi, diffondono degli affetti.[…] La lotta non difende un territorio, ma lo fa esistere, lo costruisce, gli dà consistenza».
Condividere i nemici
Il territorio, dunque, non é mai considerato un bene comune ma il risultato di particolarismi in lotta tra loro e la cui misura e forma si rendono spazialmente visibili attraverso separazioni, esclusioni, enclavizzazioni. In questi luoghi più che altrove vale quello che afferma Cornac McCarthy in Meridiano di sangue: «Quello che unisce gli uomini non è la condivisione del pane ma la condivisione dei nemici». Ma l’essere contro ha un senso solo nell’essere dentro per riuscire a sfruttare al massimo tutte le risorse che il sistema concede anche se questo comporta la chiusura definitiva dentro un recinto. Qui sta la potenza distruttiva di questi particolarismi, non rispetto al sistema ma alle sue procedure di governo e alle sue regole di controllo.
La conseguenza è una frammentazione di poteri (chi predomina e comanda a prescindere dal consenso) che si guardano bene però di assumere una veste e una organizzazione da contropotere ma cercano invece di ritagliarsi spazi di autonomia e di sfruttamento delle risorse dentro la crisi delle istituzioni e della loro capacità di governo. Un fenomeno, tra l’altro, che anche qui segnala il fallimento di ogni sintesi o di unità. E lo spazio proietta concretamente questa dimensione, ne è espressione. E così il comune, la comunità, il collettivo, lo stare insieme e altre simili utopie/distopie se vogliamo a tutti i costi andarle a cercare non ci resta che farlo nelle reti. Ma sarebbe un altro discorso che nulla avrebbe a che vedere con quello che accade sul territorio. Anche questo insegnano le periferie.
*Questo scritto è tratto dal libro di M. Ilardi, Le due periferie. Il territorio e l’immaginario di prossima pubblicazione presso l’editore DeriveApprodi.