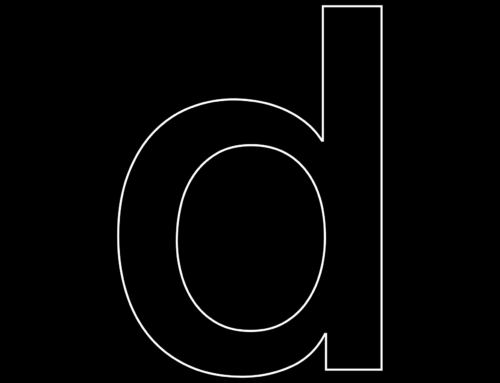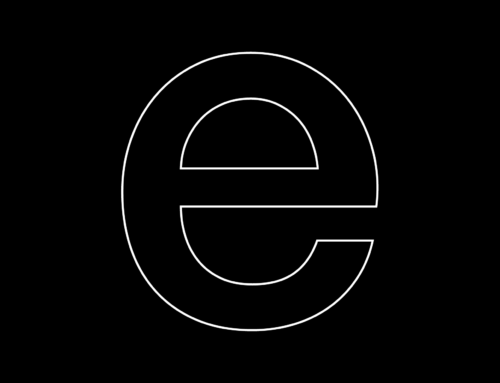Massimo Ilardi
Al posto dell’intelletto, inefficace a fronteggiare il rapido e inesauribile mutare dei desideri scatenati da una società del consumo, c’è il disincanto a proteggere l’individuo che preferisce dire di no, che non collabora e che, a differenza della figura del cittadino, è totalmente conficcato nel mondo. Ma non per rifiutarli quei desideri, in nome di una emancipazione e di un autogoverno velleitari e inconcludenti proprio perché situati fuori da ogni esperienza, ma per ristabilire una giusta distanza critica misurata sullo strapotere dell’esistente.
Il disincanto non si origina dalla razionalità, dalla secolarizzazione del mondo, dal primato della tecnica. Sembra essere piuttosto una tonalità emotiva, una disposizione dell’anima che è difficile da conquistare e ancora più difficile da governare. E’ facile che precipiti nello scetticismo di maniera o nel nichilismo assoluto se indugia troppo nel mondo delle idee o, peggio, nella delusione che assale alla fine di un percorso che ha tradito le aspettative. In verità queste sono solo le condizioni di rischio di uno “spirito” che dichiara di essere “libero”. Il disincanto è invece libero non in quanto spirito o, almeno, non solo in quanto spirito, ma in quanto sceglie di gettare nel mondo sia il suo corpo che la sua interiorità che non è inattaccabile, non si erge a fortino contro le volgarità e i piaceri della vita perché è al servizio della potenza d’agire e della forza di esistere del corpo a cui appartiene. D’altra parte, senza mondo non ci sarebbe corpo e senza corpo non ci sarebbero né spirito, né libertà. Né disincanto.
Cultura vs natura
Per capire la sua comparsa e seguire il suo percorso, bisogna volgere lo sguardo altrove e innanzitutto verso la cultura, senza la quale non ci sarebbe alcuna possibilità di approdare al disincanto che rimane sì una tonalità emotiva ma la cui origine e formazione è dentro processi culturali di lunga durata. A meno che non si intenda per disincanto la naturale tendenza di ogni essere umano a difendersi dall’eccesso di desideri ma senza farsi alcuna idea o ragione di tale tendenza. Ma non è così, il disincanto non è una disposizione naturale. E’ esperienza del mondo e insieme conoscenza dei suoi movimenti e delle sue trasformazioni, è possibilità di disporre di strumenti capaci di interpretarlo, è consapevole rinuncia alle illusioni che la tradizione e la storia accendono per difendere la loro durata e la loro continuità, è appropriazione di un proprio tempo interiore rispetto a quello esterno, è capacità di dosare una piccola quantità di senso che si deve dare alla vita ma, nello stesso tempo, di indagare il non-senso fino alle estreme conseguenze, fino “al termine della notte”: è tutto ciò a fondare il disincanto e a questo punto, ma solo a questo punto, può arrivare la possibilità di agire di conseguenza.
Ma non solo la cultura. Accanto ad essa c’è bisogno di una forte predisposizione a guardare in faccia la realtà, a non sognare altri mondi impossibili ma a vivere fino in fondo le possibilità che si parano davanti, a non pretendere mai di raggiungere qualsiasi tipo di pienezza, soprattutto quella dell’essere ma, come ammoniva Montaigne, a saper godere dell’essere così com’è. L’osservazione della realtà è diretta senza deviazioni emotive o prescrizioni morali che configurino un ‘dover essere’. Perché, avvertiva Tucidide, la natura umana è immutabile e le cose che avvengono avverranno sempre finché la natura degli uomini sarà la stessa.
Per funzionare come critica attiva, il disincanto deve dunque proiettarsi nella vita e avere dentro e davanti a sé la grande città con la mobilitazione, il lavoro, il consumo, la tecnica. Non si ritira mai dalla spazio pubblico, non rifugge dal conflitto, non è nichilismo passivo, proprio perché la sua domanda di libertà non può che esprimersi nel mondo seppure contro di esso. Ma sa che non può cambiarlo perché il mondo, come la natura umana, è un monolite impermeabile. Può prendere solo quello che già c’è. Definisce non l’illusorietà delle differenze come nel tipo blasè ma l’impossibilità di un mondo altro.
Tra il presente che non c’è più e un mondo che non c’è ancora
Il negativo è qui: nella sintesi irrisolvibile tra il presente e un mondo che non c’è più o non c’è ancora; nella contemplazione assolutamente disincantata della opposizione tra utopia e realtà. Non è fondazione di nuovi valori ma critica a quelli che già ci sono. Se la metropoli è la critica negativa nei riguardi delle sintesi tradizionali, il disincanto le interiorizza, diventa la consapevolezza tragica di questo dato. Di fronte agli aut-aut – o rinchiudersi in un convento o accettare le regole della società – sceglie quest’ultima ma rifiuta le sue regole e la sua morale. Una sorta di nichilismo attivo che dice di sì alla vita, ma che non ritiene che ci sia qualcosa oltre la vita stessa. Il disincanto, dunque, è sempre in lotta con la realtà, è condannato all’azione e dunque alla socialità. Ma l’altro è sempre considerato come una minaccia radicale alla sua libertà.
Il distacco è allora un’altra condizione essenziale per far vivere il disincanto. Se la sua origine dipende proprio dall’incontro con l’altro, dall’azione dell’altro che esercita su di noi, il passo successivo e necessario è raggiungere nei suoi confronti una distanza tale da bandire la passione per i collettivi, i pensieri in comune, i lavori di gruppo, l’eccesso di incontri, la chiacchiera smodata per acquisire invece attitudine allo studio, abilità nell’osservazione e lucidità nella riflessione, tutte condizioni che per affermarsi ricercano appunto la lontananza, la solitudine, l’assenza.
«La mia opinione –scriveva Montaigne- è che bisogna prestarsi agli altri e darsi solo a se stessi». E ancora: «Bisogna sciogliere quei legami così forti e d’ora in poi amare questa e quella cosa, ma sposare solo se stessi […] La più grande cosa del mondo è saper essere per sé. E’ tempo di staccarci dalla società poiché non possiamo darle nulla».
La vita come una somma di momenti vissuti nel presente seppure contro il presente e la consapevolezza della fine inesorabile di ogni cosa costituiscono lo sfondo dove si muovono il disincanto e i suoi personaggi.
L’uomo difficile di Hofmannsthal
Un esempio per capire. Lo fornisce Hugo von Hofmannsthal, che in L’uomo difficile fa dire all’aristocratico viennese Hans Karl, incarnazione vivente di un’intera civiltà vicina ad estinguersi e segnato da atroci esperienze di guerra: «Nulla è male. L’attimo non è male, solo non è permesso volerlo trattenere». E di fronte all’opposizione della sorella che gli rinfaccia il fatto che «noi non viviamo come certe mosche dal mattino alla sera», Hans Karl esprime con assoluto disincanto una memorabile definizione del matrimonio: “Tutto ciò che avviene, avviene per caso. Non ci s’immagina quanto accidentali noi tutti siamo, e come il caso ci avvicini e ci allontani, e come ciascuno potrebbe vivere con ciascuno, se il caso lo volesse […] Ma in questo è tale un orrore che l’uomo ha dovuto trovare qualcosa per tirarsi fuori da questo pantano per i propri capelli. E così ha trovato quell’istituto che del casuale e dell’impuro fa il necessario, il duraturo e il valido: il matrimonio.”
Ma conoscenza, realismo, distacco, presente, senso della fine sarebbero inutili se non fossero accompagnati anche qui da una domanda di libertà e dalle sue pratiche che abbattono responsabilità e impedimenti, che consentono di scivolare sulla superficie del mondo, che bollano la volontà di arrivare al fondo delle cose, oltre che un pesante fardello che schiaccia la vita, una illusione, una utopia irrealizzabile come la ricerca della verità assoluta e definitiva. «La profondità va nascosta», esortava Hugo Hofmannsthal. Ma dove? «Alla superficie», rispondeva. All’uomo non è dato di conoscere il fondo delle cose. Se incateniamo la nostra esistenza a questa ricerca senza fine, la decisione della scelta rimarrebbe sospesa a favore di un tragico immobilismo. Dunque, libertà e verità non possono coesistere.
Nell’abisso dell’anima e nella città dell’uomo non abita alcuna verità da trovare e da far conoscere, non c’è alcuna salvezza da raggiungere. E questo va detto non per un facile relativismo, ma per una raggiunta consapevolezza del significato della propria esistenza. Il problema vero non è la ricerca del senso e della verità o la difesa della interiorità o della propria autonomia ma la sopravvivenza fisica e la salvaguardia del proprio corpo. Solo la vita conta, avvertiva Ferdinand Céline, e questa è anteriore al fatto se debba o no possedere un senso. L’esistenza stessa diventa un lungo processo di apprendistato a sopravvivere cercando di dosare il senso da dare al mondo e a se stessi senza rinchiudersi però nella gabbia del nichilismo, dell’indolenza, dell’inazione. Perché troppo senso alla fine uccide, ma uccide anche l’assoluta assenza di senso.
Il disincanto compie qui una diversione: l’irrimediabile inquietudine dell’uomo, la sua radicale infirmitas vengono dirottate dalla ricerca di una salvezza improbabile a quella impervia della libertà. E’ questa domanda di libertà che non ha bisogno di pensarsi, a dare senso e orientamento nel labirinto infinito dei comportamenti possibili che si aprono dentro la società, questa società perché la libertà non è mai disancorata dal proprio tempo. Ma non potrebbero convivere neanche libertà e società. La società però rappresenta la necessità, l’intrascendibile necessità, e senza questa non esisterebbe la domanda di libertà. Non si può essere liberi nel nulla.
Il disincanto funziona, dunque, non solo come difesa dalla società del consumo che produce fantasticherie e desideri aggressivi e incontrollabili, ma anche come trampolino di lancio per proiettarsi nel mondo, perché solo nel mondo è possibile essere liberi. Non sta alla finestra spaesato e impotente a guardare quello che accade sotto di sé, scende in strada invece, anzi in trincea, con le armi della critica usate come antidoti efficaci contro le finalità etiche, i luoghi comuni edificanti e la melassa dei buoni sentimenti cucinata dall’establishment politico e mediatico che vuole imporre una legge di verità e una identità che cercano di disciplinare gli individui con regole di comportamento e obblighi morali che tendono al conformismo e alla omogeneità.